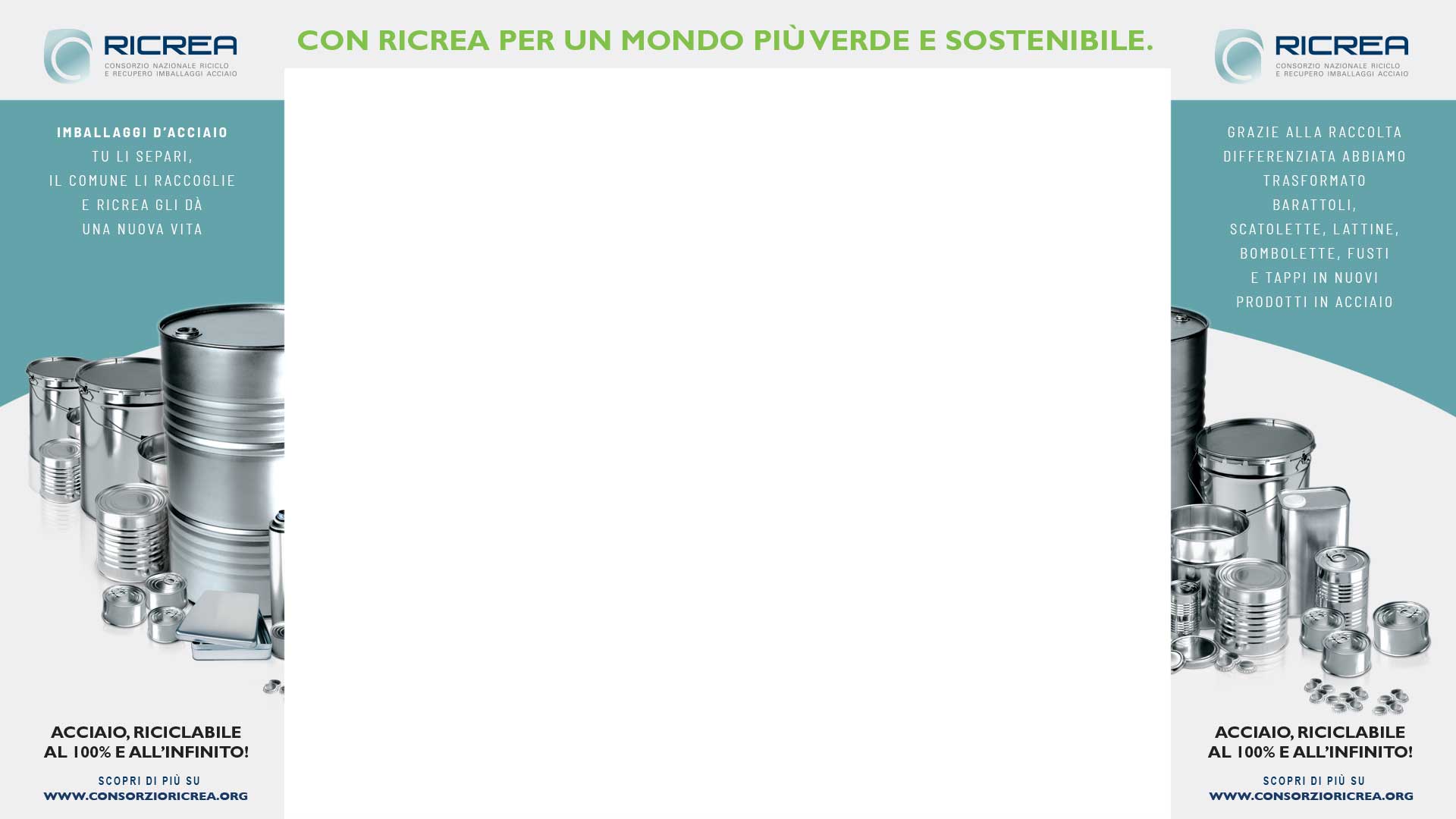di Marco Bertolino e Maria Paola Ferranti
La Nacchera (Pinna nobilis), come le cozze, per ancorarsi al fondale utilizza il bisso, un insieme di filamenti proteici secreti dalla ghiandola del bisso, che è posta alla base del piede atrofizzato. Le proteine che costituiranno i filamenti del bisso, non appena vengono a contatto con l’acqua di mare, tendono a indurirsi e a creare le fibre, lunghe anche fino a 20 cm. Il bisso, oltre a essere utilizzato dal mollusco per aderire fortemente al fondale, era sfruttato dall’uomo per tessere tessuti molto pregiati, che presero il nome di seta di mare, con una colorazione dal dorato al bronzato fino al verde oliva. Essendo la Pinna nobilis una specie protetta e, ultimamente, anche in pericolo di estinzione, lo sfruttamento del bisso non è più consentito da molto tempo. Solo una signora di Sant’Antioco in Sardegna, è ancora autorizzata e capace a lavorare il bisso per creare tessuti pregiatissimi e unici.

Esemplare adulto di Pinna nobilis. © Pinneggiando
Descrizione
Pinna nobilis Linnaeus, 1758. Nacchera. Il più grande bivalve del Mediterraneo, raggiunge dimensioni di 1 m di altezza, equivalve, di forma triangolare allungata, con l’estremità posteriore arrotondata e quella anteriore appuntita. La superficie esterna è ricoperta da lamelle squamose, meno evidenti negli individui adulti, di colore bruno, mentre quella interna è madreperlacea e rossastra. Si ancora tramite il bisso al substrato. Negli ultimi decenni è stata soggetta a pesca indiscriminata volontaria (subacquei) e involontaria (pesca a strascico) e ha subito un forte decremento, dovuto anche all’inquinamento costiero e alla riduzione delle praterie di Posidonia oceanica. È una specie fortemente epibiontata e, all’interno delle valve, si possono trovare gamberetti e granchi commensali. Inserita nell’elenco delle specie protette del protocollo SPA/BIO (Convenzione di Barcellona), Allegato II e della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”), Allegato IV.
Habitat
Vive su substrati ghiaiosi, sabbiosi o fangosi e nelle praterie di Posidonia oceanica, da pochi metri sino a 60 m di profondità.
Distribuzione
Presente in tutti i mari italiani.
L’Atlante e i suoi autori
Questa scheda è tratta dall’Atlante della flora e della fauna “Pinneggiando nei mari italiani”, frutto di anni di studio e della passione di Marco Bertolino e Maria Paola Ferranti per il mondo marino e che ha come obiettivo di mettere in risalto la complessa biodiversità dei mari italiani e di farne conoscere le meraviglie. Il volume descrive oltre 650 specie, dalle alghe ai mammiferi, ed è preceduto da un’introduzione sui principali ambienti presenti lungo le coste italiane, dalla superficie alle maggiori profondità, in un’alternanza di aree sabbiose, ciottolose e rocciose, caratterizzate da habitat marini peculiari.
Marco Bertolino e Maria Paola Ferranti sono biologi marini dell’Università degli Studi di Genova, da anni impegnati nella ricerca.
riproduzione consentita con link a originale e citazione fonte: rivistanatura.com